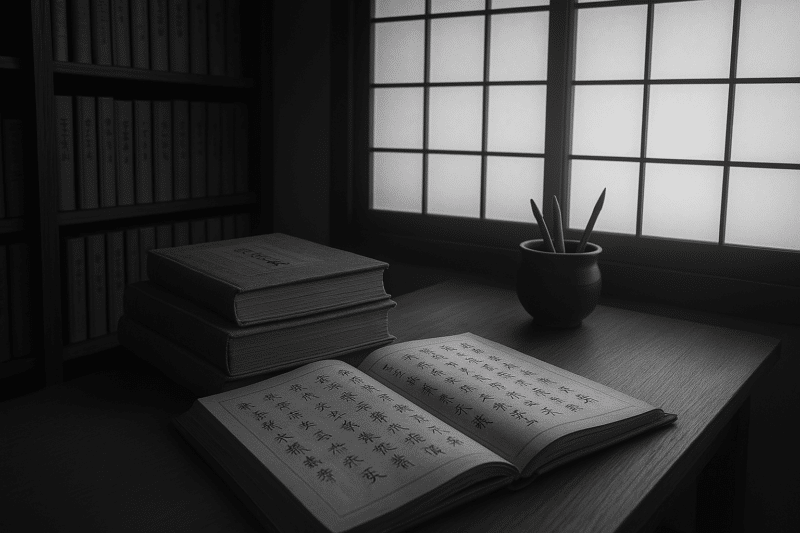Reiki consapevole
Approfondimenti
Il percorso di My Reiki nasce da un’esigenza radicale: disimparare ciò che l’Occidente ha costruito e proiettato sul Reiki, deformandone l’esperienza viva in un sistema di simboli esotizzati, semplificazioni spiritualiste e retoriche di guarigione colonizzate. Questa scuola nasce per decostruire — con rigore, ascolto e responsabilità — le immagini stereotipate che circondano il Reiki nella sua diffusione europea e americana. E nasce per interrogare il modo in cui il Reiki è stato storicamente inglobato in un sistema di sapere e potere che ha profondamente segnato la nostra cultura: l’orientalismo.
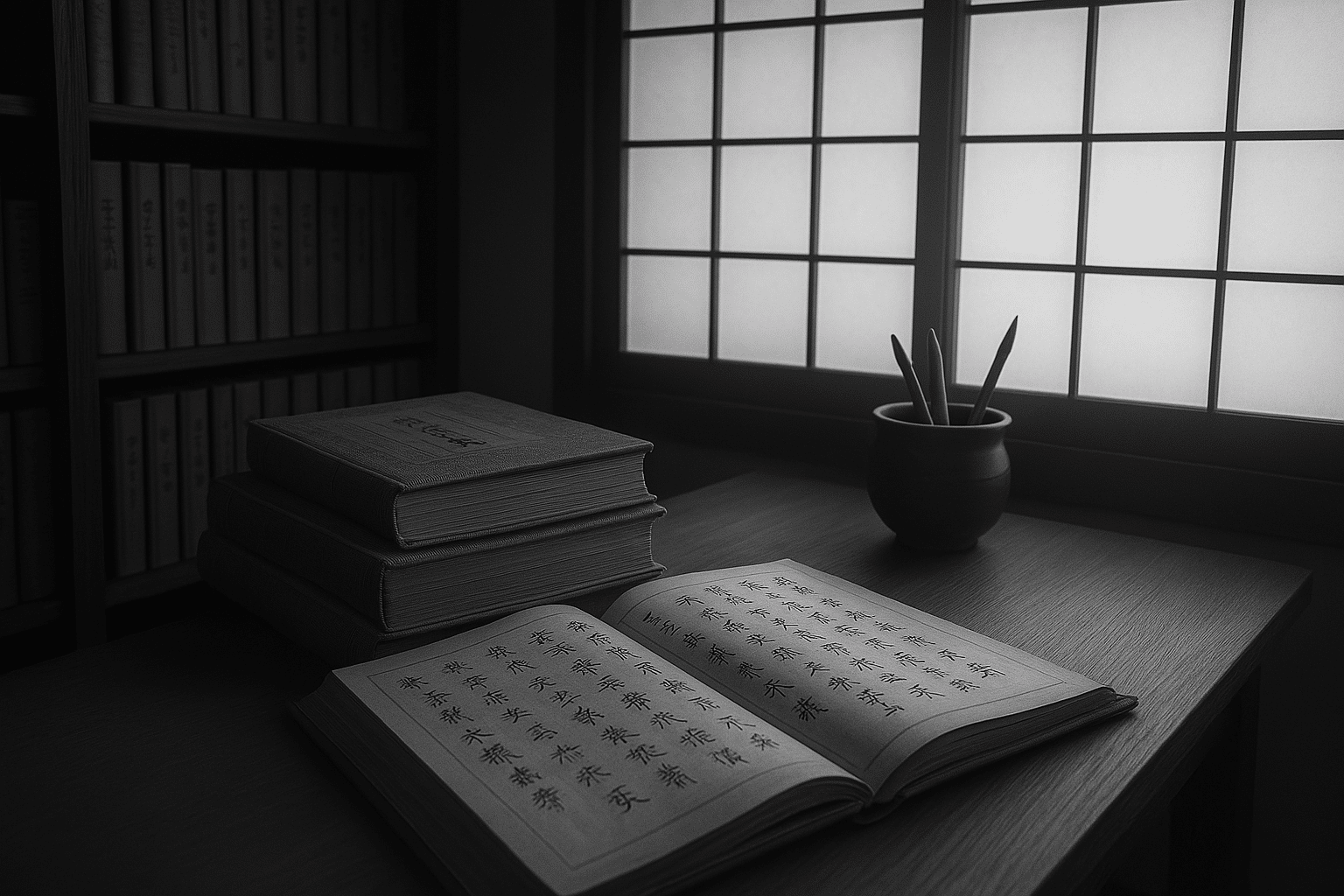
Che cos'è l'orientalismo?
Quando parliamo di orientalismo, non ci riferiamo semplicemente all’interesse per le culture asiatiche, né alla passione sincera che molte persone provano verso il Giappone. L’orientalismo, nel senso più profondo e problematico del termine, è un modo di vedere e rappresentare l’Asia costruito a partire dallo sguardo occidentale. È un insieme di immagini, narrazioni e simboli che trasformano le culture asiatiche in qualcosa di esotico, misterioso, spirituale, arcaico, seducente. Ma, proprio perché prodotte da chi guarda da fuori, queste immagini spesso non restituiscono la complessità delle culture a cui si riferiscono — e finiscono per creare un “Oriente” immaginario, funzionale ai bisogni spirituali, emotivi o commerciali dell’Occidente.
Il termine è stato teorizzato dallo studioso Edward Said nel suo libro Orientalism (1978), dove spiega come l'Europa, attraverso l’arte, la letteratura, l’antropologia e la religione, abbia costruito per secoli un’immagine dell’Oriente che lo rende inferiore, affascinante e “altro” rispetto a sé stessa. Questa immagine serve a rafforzare l’identità occidentale e a giustificare, anche inconsciamente, un rapporto di superiorità.
Reiki e chakra: un esempio di orientalismo silenzioso
Un esempio emblematico di orientalismo nella pratica del Reiki occidentale è l’uso dei chakra. Molte scuole, corsi e trattamenti Reiki si fondano su un sistema energetico basato sui sette chakra, spesso presentato come parte integrante e “naturale” del Reiki. Tuttavia, i chakra provengono da tradizioni indiane, in particolare dallo yoga tantrico e dalla medicina ayurvedica, e non fanno parte del contesto giapponese in cui Mikao Usui ha sviluppato la sua pratica.
In molte formazioni occidentali, questa sovrapposizione non viene mai esplicitata né problematizzata. I chakra vengono introdotti come se fossero una parte originaria del Reiki giapponese, in un processo che Said definirebbe orientalismo silenzioso: una fusione apparente di tradizioni asiatiche diverse, accomunate solo dal loro essere “altre” rispetto all’Occidente. È come se bastasse evocare concetti “orientali” per costruire un discorso spirituale coerente — senza preoccuparsi delle genealogie, delle pratiche, delle differenze storiche e culturali che quei concetti portano con sé.
La riscrittura occidentale dei chakra
Il sistema dei chakra così come è oggi diffuso in Occidente è esso stesso una costruzione moderna, frutto di una lunga storia di reinterpretazioni e semplificazioni. Sebbene le fonti indiane parlino di chakra come centri energetici del corpo sottile, con profonde connessioni simboliche, rituali e cosmologiche, è stato l’Occidente — a partire dalla fine dell’Ottocento — a trasformare radicalmente questo sistema.
Movimenti come la Società Teosofica hanno reinterpretato i chakra secondo schemi visivi e concettuali vicini alla sensibilità esoterica europea: associandoli ai colori dell’arcobaleno, attribuendo loro funzioni psicologiche e trasformandoli in strumenti di crescita personale. Autori come Charles W. Leadbeater hanno giocato un ruolo centrale in questa riscrittura, mentre Jung ha ulteriormente riletto i chakra in chiave archetipica, integrandoli nel proprio sistema psicologico. Tutto questo ha dato vita a una versione “occidentalizzata” dei chakra che si presenta come universale, ma è in realtà il prodotto di un’ibridazione culturalmente e storicamente situata.
Nel Reiki, adottare questo sistema senza una riflessione critica significa non solo fraintendere la pratica giapponese, ma anche perpetuare una visione orientalista che confonde, semplifica e cancella le differenze. Si crea così un “sincretismo spirituale” che più che aprire al dialogo interculturale, lo sostituisce con una spiritualità di consumo.
Un Reiki decoloniale
Nel nostro modo di praticare e insegnare il Reiki, proviamo a creare uno spazio in cui il sapere non sia un possesso, ma una relazione. Non proponiamo un ritorno all’“autenticità” — altra categoria profondamente coloniale — ma un ascolto situato, un’etica della responsabilità. Ci interessa restituire complessità alla storia del Reiki, riconoscere i suoi nodi irrisolti, le genealogie dimenticate, le discontinuità e le invenzioni. E ci interessa, soprattutto, fare i conti con il modo in cui la nostra posizione — bianca, europea, spesso privilegiata — entra in gioco nel praticare Reiki oggi.
Per questo studiamo le fonti storiche con attenzione, dialoghiamo con ricercatori accademici, ci confrontiamo con chi, nel mondo, sta cercando di costruire un Reiki che non sia un simulacro. E per questo, ogni nostro percorso formativo include momenti di riflessione critica sulla storia coloniale della spiritualità occidentale e sul modo in cui anche il Reiki è stato inglobato in quel processo.
Il Reiki come pratica relazionale
Per noi, Reiki non è una tecnica. È una pratica. E come ogni pratica, si struttura nella relazione: tra corpi, storie, paesaggi, memorie, desideri. Il nostro approccio rifiuta l’idea di un potere spirituale da acquisire e propone invece un modo di stare al mondo più attento, incarnato e consapevole.
Un Reiki decoloniale non è un Reiki più puro, ma un Reiki più consapevole. Non pretende di tornare alle origini, ma di camminare con rispetto, sapendo che ogni gesto terapeutico è anche un gesto politico.